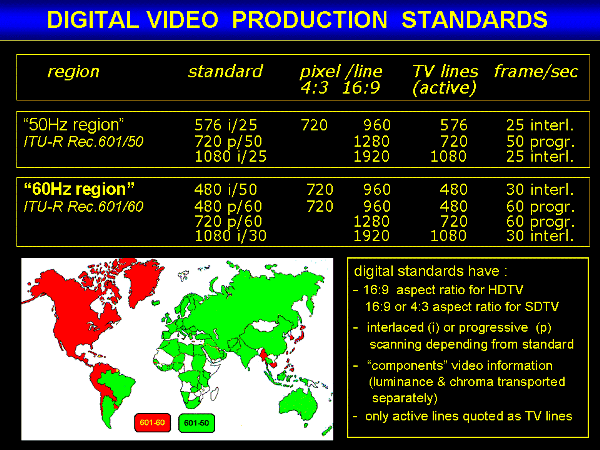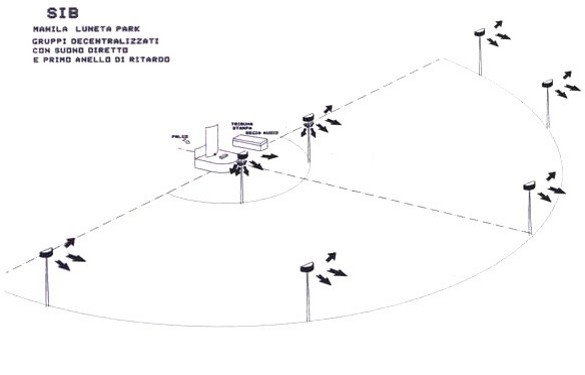|
EDITORIALE
Continuiamo il tema iniziato negli editoriali dei due scorsi bollettini e riguardante gli
standard che presiedono ai tre grandi momenti della catena audiovisiva, acquisizione,
trasporto e restituzione dei programmi audiovisivi distribuiti dalle reti (televisive,
web ed oggi anche di telefonia mobile).
Dopo aver ricordato le due grandi famiglie, SD ed HD, nelle quali oggi si articolano i
sistemi video, si è iniziato ad esaminarne le caratteristiche prendendo in
considerazione i vari parametri dell’immagine. Si è iniziato dal formato d’immagine
e dai problemi che esso può presentare nella fase di restituzione (riproduzione
sugli schermi video). Affrontiamo ora il tema di un altro importante parametro, la frequenza
di immagine, cioè la rapidità ed il modo col quale le immagini vengono
singolarmente trattate.
FREQUENZA D’IMMAGINE
E’ la frequenza con la quale le immagini vengono riprodotte dal sistema video.
E’questo l’unico parametro sul quale fortemente si differenziano ancora gli standard video
europei ed americani: il mondo è quindi ancora spaccato fra due norme:
- la norma video a 50Hz, adottata nella cosiddetta "50Hz region" costituita
da Europa, Africa, buona parte dell’Asia, Giappone e Corea e dall’Argentina, unico paese
americano ad averla adottata
- la norma video a 60Hz, adottata nella "60Hz region", adottata in tutta
l’America, Argentina esclusa, Giappone e Corea.
Tali valori (50 o 60 immagini al secondo) sono stati dettati dall’esigenza di evitare lo
sfarfallìo delle immagini riprodotte e sono stati connessi alle frequenze con cui
l’energia elettrica alternata viene distribuita nei paesi delle due "region",
ragione allora ritenuta essenziale, alla nascita della televisione fra gli anni ’40 e ’50,
per una corretta riproduzione d’immagine.
Tali norme sono ulteriormente complicate dal modo secondo il quale le righe che costituiscono
l’immagine video (il cosiddetto "quadro" o frame) vengono esplorate:
esplorazione progressiva (indicata dalla lettera "p"), se le righe vengono
esplorate una dopo l’altra in un’unica tornata, o esplorazione interallacciata
(contrassegnata con la lettera "i"), se le righe vengono esplorate in due tempi
successivi, detti "semiquadri" (fields), ciascuno formato dalle righe
intermedie a quelle dell’altro. Gli annessi riquadri ne richiamano le caratteristiche
di esplorazione. L’esplorazione interallacciata è stata utilizzata fin dall’inizio
della televisione analogica (anni ’50) per dimezzare la larghezza di banda del segnale
video (bit-rate nella TV digitale) allora improponibile per le capacità tecniche
ed economiche di quei tempi.
Il passaggio al digitale non ha ancora abbandonato l’esplorazione d’immagine interallacciata
già adottata dai sistemi analogici, affiancandola però con la più evoluta
esplorazione progressiva. Le ragioni di tali titubanze sono evidenti: il sistema interallacciato
prevede un bit-rate metà di quello necessario al sistema progressivo. Il secondo
però offre, sulle immagini in movimento, una migliore risoluzione verticale, compromessa
per il sistema interallacciata dal cosiddetto "fattore di interallacciamento" che
riduce mediamente del 30% la risoluzione verticale. Tali esigenze hanno portato a definire
un panorama degli standard video alquanto complesso (vedi Fig.1):
- gli standard SD europei sono rimasti tutti interallacciati (720x576i/25 per il formato 4:3,
960x576i/25 per quello 16:9), mentre quelli americani offrono ambedue le possibilità,
interallacciate e progressive (720x480i/30 o 480p/60 per il formato 4:3, 960x480i/30 o 960x480p/60
per il formato 16/9)
- gli standard HD, sia europei che americani e tutti in formato 16:9, offrono le stesse
possibilità: 1280x720p/50 e 1920x1080i/25 per gli europei e 1280x720p/60 e 1920x1080i/60
per gli americani.
Nel prossimo bollettino proseguiremo con l’esame di tali norme estese anche al mondo cinematografico,
oggi sempre più interconnesso con quello video grazie al cinema digitale.
esplorazione d’immagine interallacciata = le righe di ogni "quadro" vengono esplorate
in due "semiquadri" successivi, assegnando le righe fra l’uno e l’altro in modo alternato
con la loro successione geometrica. Con le norme della 50Hz region vengono in tal modo presentate
in riproduzione 50 immagini (i semiquadri). Si riduce così il pericolo di sfarfallìo d’immagine
(flicker), che viene comunque eliminato con i televisori a 100Hz ove una memoria di quadro consente
di utilizzare ogni semiquadro due volte, fornendo quindi ogni secondo 100 immagini semiquadro.
Le corrispondenti norme della 60Hz region prevedono invece 30 quadri esplorati in 60 semiquadri.
L’esplorazione interallaciata, è comunque responsabile di ridurre a circa il 70% la risoluzione
verticale d’immagine ("fattore di inerallacciamento") su immagini in movimento (vedi Fig.2).
esplorazione d’immagine progressiva = le righe di ogni "quadro" vengono esplorate
progressivamente una dopo l’altra secondo la loro successione geometrica. Rispetto alla esplorazione
interallacciata elimina la perdita di risoluzione verticale dovuta al "fattore di interallacciamento",
ma comporta un raddoppio del bit-rate del segnale video.(vedi Fig.3).
ATTIVITA’ DELLA SMPTE ITALIAN SECTION
PROSSIME MANIFESTAZIONI
4th DIGITAL CINEMATOGRAPHY FORUM 2006 – in data da definire fra il 5 ed il 9 settembre a Venezia Lido.
Anche quest’anno la Sezione Italiana della SMPTE, in collaborazione con la Mostra del Cinema di Venezia, organizza,
con la partecipazione di relatori a livello internazionale, il Forum sulla Cinematografia Digitale, giunto ormai
alla sua quarta edizione. Nei prossimi bollettini terremo informati i nostri Soci e simpatizzanti sui temi che
verranno trattati, sui nomi dei relatori e sulle data e programma del Forum.
GIORNATE DI STUDIO SMPTE.Nell’ambito dei suoi tradizionali Local Meetings, la Sezione Italiana della
SMPTE sta organizzando per i prossimi mesi delle Giornate di Studio dedicate a vari temi tecnici del momento,
quali le tecnologie adottate per lo sviluppo europeo della Televisione ad Alta Definizione ed i progressi nel
settore dell’audio cinematografico.
GIORNATA DI STUDIO "L’Audio, questo misconosciuto", 22 Febbraio 2005, Roma -Aula Magna del
Ministero delle Comunicazioni – viale Europa 90
Concludiamo l’illustrazione della relazione presentata dall’ing. Florenzo Petitta sulle moderne tecniche
di trattamento del suono già iniziata dallo scorso bollettino.
"MODERNE TECNICHE di acquisizione, registrazione e riproduzione DEL SUONO" di Florenzo
Petitta, AES, Radio Vaticana.
Proseguendo nel suo esame sull’ACQUISIZIONE AUDIO, Petitta ha rilevato la recente crescita esponenziale
nell’uso dei radio-microfoni. In televisione l’impiego del radio-microfono si è diffuso a macchia
d’olio. Non c’è programma "in diretta" che non lo utilizzi in dosi massicce, dai talk-show,
ai vari format, alla manifestazioni canore come S. Remo, ecc. In molti teatri di prosa mediante i
radio-microfoni e buone amplificazioni, gli attori hanno migliorato notevolmente il rapporto con il
pubblico non essendo più costretti a forzare la voce per essere ascoltati da tutti. Di questo vantaggio
ne hanno goduto anche i cantanti lirici in molte rappresentazioni che si svolgono in luoghi storici (previsti
dai libretti dell’opera). Famose sono rimaste a tale riguardo le esecuzioni RAI in Mondovisione della Tosca
da Castel S. Angelo e della Traviata da Parigi (dove sono stati usati circa 200 radio-microfoni).
Passando alla REGISTRAZIONE AUDIO il relatore ha ricostruito il suo sviluppo storico ricordando che ad
ognuno dei formati apparsi in commercio ha corrisposto una tecnologia nuova con la quale gli addetti ai
lavori si sono dovuti misurare per aggiornare i loro apparati e il loro know-how. Partendo dai primi
giradischi (le lacche in acetato contenevano circa 30 min di incisione) e dai registratori magnetici a
due tracce, ingombranti, pesanti (100-300Kg) e con prestazioni limitate (le registrazioni duravano 30 min.
(con velocità del nastro di 38cm/s) o 60 min (a 19cm/s), negli anni 70’-80’ uscirono vari sistemi di
registrazione multi-traccia che, unitamente a schede elettroniche tipo Dolby, Telcom, ecc. (per la riduzione
del rumore di fondo dei nastri), sono ancora oggi preferiti in molti studi di produzione per la registrazione
su 24 piste. Dagli anni 90’ poi sono disponibili vari registratori a due tracce e multitraccia per la
registrazione digitale su più canali. Ne esistono di tutte le fasce di prezzo a seconda dello standard
qualitativo richiesto. Ad essi sono poi seguite le musicassette, i CD (Compact Disc), i minidisc, le cassette
DAT (Digital Audio Tape), gli HD (Hard Disc) fino agli attuali MP3, per parlare dei soli formati audio.
Il tipo di supporto più utilizzato al momento per le registrazioni, non solo professionali, è
l’hard-disc montato nei personal computer. Esiste anche una grande quantità di programmi, con i quali
realizzare registrazioni musicali di ottima qualità mediante l’uso di "sintetizzatori",
"campionatori" e altre schede di qualità digitale. Molti registratori professionali usano
poi stazioni dedicate, con molte schede aggiuntive( plug-in) scelte a seconda delle prestazioni che si
richiedono.
Per quanto riguarda le prestazioni di tali sistemi avanzati Petitta ha sottolineato la possibilità
di accesso istantaneo a qualsiasi traccia. Coi registratori analogici era infatti necessario svolgere
il nastro per raggiungere il punto che interessava. Vi è poi oggi la possibilità di
visualizzare e intervenire sulla forma d’onda del suono registrato, quella di Copia / Incolla e tutte
le altre operazioni di editing elettroniche tipiche di un computer. E inoltre si può operare a
48 tracce, 24 bit 44.1- 48 KHz, oppure a 24 tracce, 24 bit 88-96 KHz ed a 72 GB SCSI con 208 o 256
tracce virtuali.
Un Petitta in gran forma ha chiuso la sua ampia rassegna ricordando la progettazione di impianti di
Rinforzo Sonoro a Diffusione Distribuita (Fig.4). Questa deve tener conto di moltissimi parametri
che possono essere inseriti in programmi di simulazione acustica in grado di fornire, con buona
approssimazione, indicazioni sulla posizione dei diffusori e sui materiali da usare per gli ambienti.
Ha anche citato esempi di rinforzo sonoro in spazi aperti, con gruppi di ritardo disposti su traiettorie
lineari o circolari, che si prestano ad amplificare suoni per milioni di persone.
Concludendo, ha osservato che non tutti i problemi audio possono essere risolti dalla innovazione tecnologica,
ma coniugandola con la professionalità e l’esperienza è possibile far si che l’audio diventi
uno strumento più docile al nostro servizio.
SMPTE – Bollettino della Sezione Italia
c/o Franco Visintin
e-mail : franco.visintin@smpte.it
SMPTE website : http://www.smpte.org
SMPTE-Italy website: http://www.smpte.it
|
|